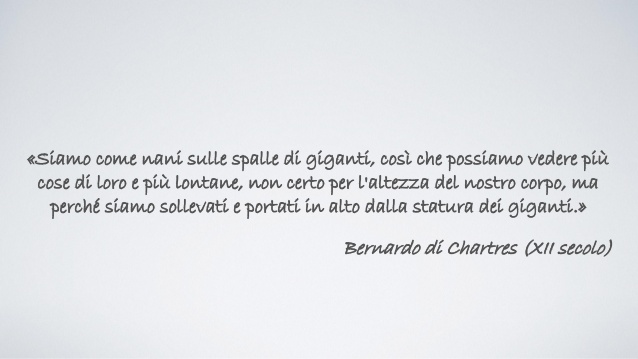Thioro, un Cappuccettorosso “nero” in cerca di identità
A cosa servono le favole? A parlare attraverso archetipi capaci di raggiungere trasversalmente l’umano che ci accomuna tutti. Puoi chiamarlo Omero, aedo, cantastorie, menestrello, puparo o griot, ma quel che intendi è sempre l’ammaliatore capace di raccontare, trasmettendo la memoria comune attraverso un’evocazione condivisa.
E non è questo, in fondo, quel che fa anche il teatro? Perfino quello borghese, per sua natura più legato a tematiche e dinamiche individualiste, ci accoglie nel cerchio magico del suo salotto buono, con tanto di caminetto/fuoco, per raccontarci storie quali minuscoli exempla in grado di significare ben al di là della loro povera contingenza. Spesso non si tratta nemmeno di insegnare – educare, poi, sarebbe ambizione eccessiva –, quanto di condividere. Un gesto piccolo e prezioso come quello di chi, seduto sulla soglia, fosse tutto intento a sgranare i suoi baccelli: al passante, poi, l’onere di riconoscerli o assaggiarne il frutto, se lo desideri.
E se questo fa il teatro autentico, che nasce dall’esigenza del singolo, sì, ma che poi si compie soltanto nell’incontro con lo speculare bisogno dell’altro, va da sé che Teatro primariamente – e primordialmente – è quello che sia capace d’intercettare paradigmi così ancestrali da abitare nell’epos di ogni cultura. Ecco perché è quanto mai giusta l’intuizione di Teatro delle Albe di meticciare tradizioni e culture alla scoperta dei segmenti comuni di dna pur nella diversità delle declinazioni locali. Apparteniamo tutti alla stessa specie, anche se poi ogni razza e ogni singolo individuo incarna questa figliolanza nella propria irripetibilità.
È così che nasce “Thioro. Un Cappuccettorosso senegalese”. Lo spettacolo, per grandi e piccini, è andato in scena nella doppia replica di venerdì 13 luglio 2018 al festival “Da vicino Nessuno è Normale” (in chiusura il 21 luglio). Un progetto pensato e ambizioso, che vede coinvolti più partner – Teatro delle Albe/Ravenna Teatro, Accademia Perduta/Romagna Teatri e Ker Théâtre Mandiaye N’Diaye –, eppure di una fruibilità e godibilità assolutamente agili. Già perché il lavoro e la fatica sono oneri di chi fa; quando sia ben orchestrato, allo spettatore arriva soltanto la leggerezza del non a caso jouer au théâtre.

Sotto la regia di Alessandro Argnani, nel cerchio magico Adama Gueye griot a duettare col trombettista Simone Marzocchi e col percussionista Fallou Diop, creatori di ambientazioni ed atmosfere magiche, grazie a un uso non sempre convenzionale degli strumenti (che a volte suonano, altre ragliano o nitriscono a suggerire suggestioni inaspettate). È l’incontro fra due culture da cui nacquero, ormai trent’anni or sono, le Albe afro-romagnole, qui felicemente sottolineate dal parodistico pastiche iniziale fra i due musici. Capovolgendo la prassi italiota del caratterizzare le persone in base alle loro abitudini alimentari, qui è Diop a scimmiottare Marzocchi al motto di: “Tortellini, tagliatelle…”. Dice del graduale incontro fra culture, che, come nella vita, anzitutto passa attraverso un approccio/scambio linguistico oltre che, probabilmente di condivisione di saperi e di sapori… È il cortocircuito per cui si passa dalle latitudini mittel europee di una non meglio identificata Foresta Nera – luogo di passaggio e incontro col forestiero – al minuscolo villaggio di Diol Kadd, nella savana senegalese. Qui puoi non incontrare nessuno per giorni, ma se le incontri di notte, non puoi chiamare le persone col loro nome, se no gli Spiriti glielo rubano. E non è importante cosa indossi – Cappuccetto Rosso -, ma chi sei – Thioro, che nella lingua animista significa: “Amore mio” -: così nelle parole del cantastorie veniamo reinventati tutti novelli Thioro.


La trama è grosso modo quella; eppure sta nei dettagli la preziosità di una saggezza popolare non ancora messa a tacere dalle parcellizzanti tecnologie di massa. La nonna è sì quella di Thioro, eppure ricorda tanto Tana, la nonna-sciamana della protagonista del cartone disneyano “Oceania”. Era alla sua capanna che andavano tutti i bambini del villaggio per ascoltare le storie. “Quando i bambini tornavano alle loro capanne, era successo qualcosa: erano un po’ cresciuti…”, spiega il griot, che subito rincara: “Quando muore un anziano, è come se una biblioteca bruciasse”. E infatti non è per assolvere a un pietistico compito di accudimento che la bambina sfida le insidie della savana. Lo fa per soddisfare la propria fame di storie. Il pericolo non è il lupo famelico, ma la non meno scaltra iena Buky, a cui pure è riconosciuto un nome. Definita come l’animale più forte e più cattivo, si mostra nella straordinaria plasticità mimica di Gueye, L’attore è abilissimo non solo nell’impersonare gli animali della savana o la prossemica dei protagonisti, ma riesce a farci vedere, attraverso i suoi occhi spalancati dalla meraviglia, gli sterminati orizzonti di quella terra e le stelle, che, certe notti, nulla hanno da invidiare alle luci di Dakar. Ma c’è di più, in quella fisicità incondizionata: c’è la tradizione di danze ancestrali e tutta la saggezza di corpi, che non hanno ancora abdicato al diktat estraniante dell’ hikikomori. Sarebbe fin troppo facile alludere a un parallelismo con le forze fresche e vitali che diedero nuova linfa all’Impero Romano in decadimento – pur decretandone la fine/evoluzione -; quel che resta vero è che abbiamo assistito ad uno spettacolo politico ed éngangé , capace, nella morbida coltre della favola, di mostrare a noi e ai nostri bambini dove siamo e dove stiamo andando: piaccia o non piaccia. Non a caso quel finale. Mentre allude soltanto al divorare – così come vagamente s’insinua ai tanti cacciatori, che si aggirano per la savana -, preferisce invece sublimare in un ballo coinvolgente e dalle tonalità meticce, capace di tirar tutti dentro al cerchio magico.